Caterina, una mistica mandata da Dio nella politica per riconciliare l’Europa e l'Italia
La prima opera di riconciliazione è Avignone.
Da circa 70 anni papi risiedevano in quella città della Francia protetti aiutati dal re di Francia, in quella che fu detta una specie di cattività babilonese. Roma priva della sede pontificia era ridotta un piccolo borgo afflitto da predoni pestilenze e miseria. Gli spiriti più eletti, come Dante e Petrarca, avevano invano invocato il ritorno del Papa alla sua sede. Santa Brigida di Svezia si era adoperata grandemente per questo ritorno, ma non era riuscita nel suo intento.
La permanenza del Papa ad Avignone causava gravissimi inconvenienti per la chiesa e per l'equilibrio politico europeo.

La soggezione al re di Francia che custodiva come una prigione dorata la corte pontificia aveva un riflesso evidente sulla vita della chiesa: al tempo di Santa Caterina il Papa Gregorio XI - come sei suoi predecessori - era francesi e francesi hanno quasi tutti i cardinali.
La lontananza del Papa degli Stati Pontifici facilitava le agitazioni e le sommosse le contese e le ribellioni di cui erano spesso motivo i governatori francesi che abusavano del loro potere e per domarlo e mantenere soggette quelle popolazioni egli era costretto a inviare i cardinali e vescovi suoi legati a fianco di capitani di ventura che rimettevano temporaneamente le cose a posto, ma compirono stragi e saccheggi come la tristemente celebre “strage di Cesena” accaduta al tempo di Santa Caterina…
Lo stesso vescovo di Siena che dal 1371 al tre 1377 fu il francese Guglielmo di Guascogna, non gradito ai senesi che volevano un vescovo cittadino, se ne stava allora ad Avignone non compare mai nella vita e negli scritti di Caterina.
Preso da tante preoccupazioni carattere temporale il Papa non ha tempo e forze per occuparsi delle cose spirituali. La simonia, la decadenza dei costumi, l'avidità del potere e delle ricchezze, il desiderio di possedere “palazzi e grossi cavalli“ (come diceva Caterina) avevano ridotto la chiesa in uno stato deplorevole. Solo il ritorno del Papa Roma avrebbe potuto favorire la "riforma della Santa Chiesa”.
Santa Caterina volle fermamente questo ritorno e per questo scrisse al Papa Gregorio XI ben 14 lettere e si recò di persona accompagnata dal B. Raimondo e da altri della sua famiglia spirituale ad Avignone. Vi arrivò il 18 giugno 1376; poté parlare col Papa; la sua parlata senese veniva tradotta in latino dal B. Raimondo; riuscì nel suo intento. Il Papa il 13 settembre si imbarcò Marsiglia per tornare a quello che Caterina chiamava “il luogo suo”. A Genova il Papa ebbe ancora esitazione e Santa Caterina lo rincuorò. Il 17 gennaio 1377 Egli entrò a Roma, non tanto “con sforzo di cavalli e di armati”, ma piuttosto “con la croce in mano” come “Agnello mansueto” (lettera 229), come Caterina gli aveva consigliato, e fu accolto trionfalmente.
Da quel momento cambiava la storia di Europa: Caterina aveva riconciliato il Papa con Roma e Roma con il Papa va ridato libertà alla sede di di Pietro, per riformare la Chiesa e farne più che mai l'anima cristiana d’Europa.
Caterina perciò capovolse il corso della storia europea: non possiamo neppure immaginare quale sarebbe stata la storia d'Europa, se il Papa fosse rimasto definitivamente in Avignone!
(Mario I. Castellano, Santa Caterina da Siena e l’Europa, Edizioni Cantagalli, Siena 1981, pp. 8-10)
… e l’Italia
[…] Caterina perseguì durante la sua vita pubblica anche l'intento di riconciliazione di pace fra i principi e governanti tra le città d'Italia e all'interno delle città tra le famiglie e le consorterie tra i governanti e il popolo ad essi affidato in particolare per riconciliare Stati e città col Papa …
Per capire quanto sia stata vasta quest'azione della Santa basta scorrere il suo epistolario: oltre alle lettere indirizzate ai papi Gregorio XI Urbano VI, a Cardinali Arcivescovi, Vescovi , Abati, Monaci e Prelati vi sono quelle indirizzate a Carlo V re di Francia, Luigi d'Angiò suo fratello a Carlo Durazzo Re di Puglia, a Ludovico re d'Ungheria e di Polonia ad Elisabetta regina d’Ungheria, a Giovanna regina di Napoli ,a Bernabò Visconti signore di Milano, Onorato Gaetani conte di Fondi , ai Belforti signori di Volterra, a Pietro Gambacorti signore di Pisa, ai difensori del popolo di Siena, Lucca, Firenze, Perugia, Borgo Sansepolcro, Foligno, Bologna, Sanseverino Marche, Mileto, Roma; ai capitani di ventura Giovanni Acuto (inglese) Tommaso d’Alviano e Alberico di Balbiano ecc.
E’ un epistolario quello Cateriniano che rivela un'azione di vera dimensione europea ed esso si possono ricavare delle massime di reggimento civile o principi di dottrina politica che hanno sapore di modernità e sarebbero accettate da ogni europeo sinceramente democratico.
(Ivi, p. 13).
Patrona d’Europa
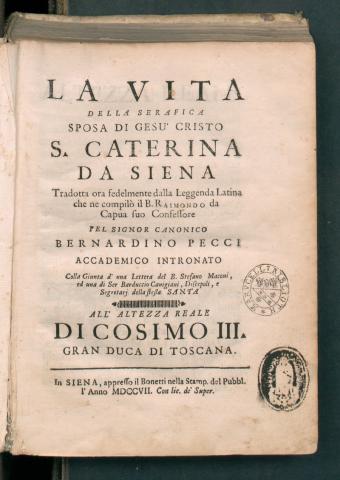
n. 6 […] Nata a Siena nel 1347, fu favorita sin dalla prima infanzia di straordinarie grazie che le permisero di compiere, sulla via spirituale tracciata da san Domenico, un rapido cammino di perfezione tra preghiera, austerità e opere di carità. Aveva vent'anni quando Cristo le manifestò la sua predilezione attraverso il mistico simbolo dell'anello sponsale. Era il coronamento di un'intimità maturata nel nascondimento e nella contemplazione, grazie alla costante permanenza, pur al di fuori delle mura di un monastero, entro quella spirituale dimora che ella amava chiamare la «cella interiore». Il silenzio di questa cella, rendendola docilissima alle divine ispirazioni, poté coniugarsi ben presto con un'operosità apostolica che ha dello straordinario. Molti, anche chierici, si raccolsero intorno a lei come discepoli, riconoscendole il dono di una spirituale maternità. Le sue lettere si diramarono per l'Italia e per l'Europa stessa. La giovane senese entrò infatti con piglio sicuro e parole ardenti nel vivo delle problematiche ecclesiali e sociali della sua epoca.
Instancabile fu l'impegno che Caterina profuse per la soluzione dei molteplici conflitti che laceravano la società del suo tempo. La sua opera pacificatrice raggiunse sovrani europei quali Carlo V di Francia, Carlo di Durazzo, Elisabetta di Ungheria, Ludovico il Grande di Ungheria e di Polonia, Giovanna di Napoli. Significativa fu la sua azione per riconciliare Firenze con il Papa. Additando «Cristo crocifisso e Maria dolce» ai contendenti, ella mostrava che, per una società ispirata ai valori cristiani, mai poteva darsi motivo di contesa tanto grave da far preferire il ricorso alla ragione delle armi piuttosto che alle armi della ragione.
n. 7. Caterina tuttavia sapeva bene che a tale conclusione non si poteva efficacemente pervenire, se gli animi non erano stati prima plasmati dal vigore stesso del Vangelo. Di qui l'urgenza della riforma dei costumi, che ella proponeva a tutti, senza eccezione. Ai re ricordava che non potevano governare come se il regno fosse loro « proprietà »: consapevoli di dover rendere conto a Dio della gestione del potere, essi dovevano piuttosto assumere il compito di mantenervi «la santa e vera giustizia», facendosi « padri dei poveri » (cfr Lettera n. 235 al Re di Francia). L'esercizio della sovranità non poteva infatti essere disgiunto da quello della carità, che è insieme anima della vita personale e della responsabilità politica (cfr Lettera n. 357 al Re d'Ungheria).
Con la stessa forza Caterina si rivolgeva agli ecclesiastici di ogni rango, per chiedere la più severa coerenza nella loro vita e nel loro ministero pastorale. Fa una certa impressione il tono libero, vigoroso, tagliente, con cui ella ammonisce preti, vescovi, cardinali. Occorreva sradicare — ella diceva — dal giardino della Chiesa le piante fradicie sostituendole con «piante novelle» fresche e olezzanti. E forte della sua intimità con Cristo, la santa senese non temeva di indicare con franchezza allo stesso Pontefice, che amava teneramente come «dolce Cristo in terra», la volontà di Dio che gli imponeva di sciogliere le esitazioni dettate dalla prudenza terrena e dagli interessi mondani, per tornare da Avignone a Roma, presso la tomba di Pietro.
Con altrettanta passione, Caterina si prodigò poi per scongiurare le divisioni che sopraggiunsero nell'elezione papale successiva alla morte di Gregorio XI: anche in quella vicenda fece ancora una volta appello con ardore appassionato alle ragioni irrinunciabili della comunione. Era quello l'ideale supremo a cui aveva ispirato tutta la sua vita spendendosi senza riserva per la Chiesa. Sarà lei stessa a testimoniarlo ai suoi figli spirituali sul letto di morte: «Tenete per fermo, carissimi, che io ho dato la vita per la santa Chiesa» (Beato Raimondo da Capua, Vita di santa Caterina da Siena, Lib. III, c. IV).
(Giovanni Paolo II, Spes Aedificandi, Lettera Apostolica in forma di "Motu proprio" per la proclamazione di Santa Brigida di Svezia, Santa Caterina da Siena e Santa Teresa Benedetta della Croce Compatrone d'Europa, 1999, nn. 6-7).