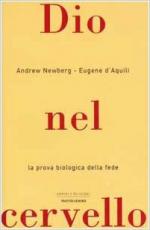Andrew Newberg-Eugene d’Aquili, Why God Won’t Go Away. Brain Science and the Biology of Belief, Ballantine Books, New York 2001. Tr. it.: Dio nel cervello. La prova biologica della fede, Mondadori, Milano 2002.
Il libro Why God Won’t Go Away. Brain Science and the Biology of Belief, pubblicato nel 2001, compare l’anno successivo in lingua italiana con un titolo che ne qualifica il contenuto in termini riduzionisti ben aldilà delle intenzioni degli autori e del titolo originario: Dio nel cervello. La prova biologica della fede. Esso ha un valore, in ristretta misura, epocale, in quanto introduce nel contesto culturale contemporaneo un nuovo ambito di ricerca, denominato “neuroteologia”, che studia i correlati neurali dell’esperienza religiosa. Il testo non è certo il protocollo del primo studio sperimentale in tale campo, ma rappresenta il primo tentativo, riuscito, di armonizzare in un’unica cornice quanto fino ad allora emerso e di proporne un’elaborazione teorica estesa e fondativa. Gli autori sono Andrew Newberg, docente di Radiologia presso il Dipartimento di Medicina nucleare dell’Università di Pennsylvania, e il collega Eugene d’Aquili: in realtà, quest’ultimo era già deceduto da tre anni al momento dell’uscita del libro, ma Newberg, nel rispetto del ruolo di guida del collega, ha voluto che fosse riconosciuto il binomio autoriale.
L’esperimento iniziale
Il libro si apre con il famoso reportage sulla tomografia del cervello di un monaco buddhista tibetano in un picco di meditazione. Il resoconto è avvincente: il monaco si trova, nella tradizionale posizione yoga del fior di loto, in una piccola stanza del Policlinico universitario della Pennsylvania allestita per l’occasione, secondo le sue richieste, a luogo di meditazione, spoglio, penetrato da poca luce e accessoriato con qualche candela accesa e un bastoncino di incenso al gelsomino. Il monaco si trova solo nella stanza ed è in contatto con il mondo esterno, nella fattispecie con il gruppo di lavoro che lo sta studiando, tramite due elementi: un filo di cotone legato al suo dito indice che passa sotto la porta e conduce al dito del dott. Newberg e un tubicino inserito in una vena del suo braccio sinistro che faceva il medesimo tragitto. Dopo circa un’ora di attesa, Newberg sentì un leggero strappo della cordicella. Era il segnale: il monaco avvertiva l’avvicinarsi del picco di trascendenza e i medici, immediatamente, introdussero un composto radioattivo lungo il tubicino e, dopo qualche secondo, entrarono nella stanza per prelevare il monaco, trasportarlo in fretta nel reparto della SPECT (tomografia computerizzata a emissione di fotoni singoli) e sottoporlo alla scansione cerebrale. Poiché il tracciante radioattivo viaggia nel flusso sanguigno e si combina subito con i neuroni, rimanendo in loco per ore, fu possibile analizzare la circolazione sanguigna del cervello del monaco, verificando l’attività delle varie aree.
Con un certo gusto per la suspense, gli autori narrano quindi l’inatteso risultato. Le immagini ottenute infatti mostravano una forte riduzione dell’attività cerebrale (deafferentazione) nell’area associativa dell’orientamento che, ordinariamente, non rimane mai inattiva nel corso della vita cosciente. Essa infatti, situata nel lobo parietale superiore posteriore, è deputata, nella parte destra,al controllo dello spazio fisico dell’ambiente in cui ci troviamo, mentre, nella parte sinistra, alla cognizione dei limiti fisici del proprio corpo. Tale area dell’orientamento riceve costantemente gli impulsi nervosi di ciascun senso ed elabora l’imponente mole di dati con una velocità e una potenza che fa ancora invidia ai super-computer più avanzati. Proprio per questo suo ruolo e per tale impegnativo lavoro essa non può permettersi di ridurre la propria attività. Nel caso del picco di trascendenza, invece, tale area risultava temporaneamente ‘spenta’ in entrambe le parti.
Gli autori passano quindi alla lettura dei dati: quando l’area dei confini del sé non riceve informazioni sensoriali da elaborare e non può fornire indicazioni alle altre parti del cervello, ecco che il soggetto ha la sensazione dello smarrimento, della rarefazione e della perdita dei propri limiti corporei. Non trovando più, nello spazio fisico, la ‘forma’ del proprio corpo, la coscienza va a cercare informazioni nell’ambiente circostante, ma se anche questo non dà segni di sé, ecco che il soggetto sperimenta quel senso di infinito e di identificazione con il Tutto che costituisce il nucleo delle narrazioni dei maestri di meditazione, principalmente di scuola orientale. L’immagine della goccia che si dissolve nel tutto dell’oceano, tanto frequente nelle testimonianze dei mistici, è certamente la più idonea - concludono gli autori – per descrivere la sensazione di colui che sperimenti l’accecamento dell’area dell’orientamento, sia per quanto riguarda i propri confini fisici, sia per quanto è relativo all’ambiente circostante. Lo studio di altri sette monaci buddhisti in meditazione presentava gli stessi esiti e avvalorava la tesi (cfr. pp. 15-16).
Con il capitolo VI, la casistica si estende con lo studio sperimentale di esperienze mistiche da parte di suore francescane, il cui metodo di meditazione innesca una sequenza di attività neurali leggermente diversa. A differenza del monaco buddhista che cerca di bloccare ogni informazione dal mondo esterno, generando così una sensazione soggettiva di assoluta mancanza di limiti e immenso vuoto, le suore francescane – annotano gli autori - attuavano simili tecniche meditative concentrandosi intensamente, anziché sull’assenza di stimoli (puro nulla), su un’immagine di Gesù Cristo o sul simbolo della croce. In questo modo, la parte sinistra dell’area dell’orientamento (limiti del sé) non riceveva più informazioni, ma la parte destra (ambiente circostante), totalmente concentrata sull’immagine sacra, raccoglieva un flusso imponente di sensazioni da essa, finendo per identificare l’immagine con l’intera realtà esterna. Anche il cervello delle religiose, come quello del monaco, perdeva i confini del proprio io, ma, invece di smarrirli indefinitamente nel tutto, li ritrovava marcatamente definiti nell’immagine sacra, con la quale veniva a identificarsi completamente, dando ragione alle descrizioni di unyo mystica del genere di quella esemplarmente riferita da Angela da Foligno riportata nel testo, secondo cui: “Non sono più nel mondo in cui mi trovo; sono nella pace in cui sono tutt’uno con Gesù e godo di tutto” (cfr. pp. 16-17 e 123-126).
I dualismi mente-cervello e realtà-percezione
Una volta appurato, grazie alle più avanzate strumentazioni tecnologiche, che le esperienze spirituali hanno un preciso correlato neurale – come è ovvio per ogni tipo di esperienza del soggetto – per gli autori inizia la parte difficile, ovvero prendere una collocazione nell’ampio spettro delle possibilità che la filosofia della mente ha dispiegato. Uno spettro che la letteratura critica ha ormai ben definito e vede, ad un estremo, il riduzionismo eliminitavista à la Paul Churchland (Il motore della ragione, la sede dell’anima, Il Saggiatore 1998; The Neural Basis of Human Belief Systems, Krueger-Grafman 2013), secondo cui esiste solo il correlato neurale ed ogni aspirazione a farvi corrispondere una realtà oggettiva è una pia illusione da sopprimere e, all’altro estremo, il neomisterianesimo di Owen Flanagan per cui la dimensione spirituale è una certezza, ma ogni tentativo di comprenderla è aldilà delle potenzialità umane, tanto più se ci si prova con mezzi scientifici o, nel nostro caso, neuroscientifici. Tra i due poli, naturalmente, sussiste una vasta varietà di posizioni dalle molteplici sfumature più o meno marcate.
Gli autori, in realtà, non prendono una posizione particolare, dichiarano metodologicamente di attenersi ai dati, diffidando esplicitamente da ogni tentativo di trarre dall’indagine qualcosa che vada aldilà dei dati stessi: “L’indagine sui buddhisti tibetani e sulle suore francescane ha dimostrato che gli eventi da loro ritenuti spirituali erano in realtà associati a un’attività nervosa osservabile. In un’ottica riduzionistica, ciò potrebbe suffragare l’ipotesi che l’esperienza religiosa sia, dal punto di vista neurologico, soltanto immaginaria; che, fisicamente, Dio sia ‘solo nella testa’. Eppure, sapendo con dovizia di dettagli in che modo il cervello e la mente elaborino ed esperiscano la realtà, tendiamo a pensare che le cose stiano diversamente” (p. 44). Con un semplice esempio gli autori riescono a spiegare bene il loro punto di vista: se sottopongo all’esame della SPECT anziché il cervello di un monaco buddhista in un picco di meditazione, quello di una persona qualunque che sta assaporando una gustosa torta di mele, vi rileverò necessariamente peculiari attività neurali in determinate aree, ma tali risultati non permettono certo di dire che la torta sia ‘solo nella testa’ e che tale esperienza sia soltanto immaginaria. Se ogni esperienza mentale dovesse creare sospetto perché è indubbiamente collegata ad un’attività neurale, allora «dovremmo diffidare di tutte le percezioni che l’encefalo ha del mondo materiale» (p. 149). Pertanto, «il fatto che l’esperienza religiosa dipenda da un’attività neurale non smentisce la realtà del fenomeno» (p. 44). Nell’VIII e penultimo capitolo, la tesi è ribadita: «Intendiamo dunque dire che Dio è solo un’idea e che non contiene più verità assoluta di una fantasia o un sogno? Se ci basiamo sulla conoscenza che abbiamo attualmente del modo in cui la mente interpreta le percezioni del cervello, la risposta più diretta è ‘no’. La neurologia del cervello non può né provare né confutare l’esistenza di Dio» (p. 146).
Con questa conclusione che si attiene rigorosamente ai dati neurologici e si astiene metodologicamente dal formulare ipotesi intorno alla fonte, o causa, dei dati medesimi, la cornice dell’obiettività scientifica è salvaguardata. Lo statuto galileiano della scienza moderna, che limita l’area di pertinenza a ciò che è misurabile oggettivamente, è rispettato e viene fatto salvo anche quel principio che il Dalai Lama – molto attento agli studi neuro-scientifici della spiritualità - ebbe modo di ben esprimere nella premessa al testo Essere distruttivi scritto con Daniel Goleman: «va tracciata una chiara distinzione tra ciò che la scienza non scopre e ciò che la scienza scopre come inesistente» (Mondadori 2004, p. 6). A parte dunque alcune espressioni sulla cui precisione si potrebbe dibattere, come quella per cui l’esperienza “dipende” dall’attività neurale nella citazione sopra riportata o quella secondo cui il cervello “produce” la mente (p. 41), il testo mantiene una solida correttezza di procedura e una prudenza ineccepibile, anche se, in ultima istanza, la conclusione finisce un po’ per deludere le aspettative del lettore, limitandosi a sottoscrivere che le pratiche meditative, orientali o occidentali che siano, attivano una peculiare dinamica neurale.
Dopo aver fatto tappa sull’architettura del cervello (capitolo III) e sulla funzione del ‘rito’, capace di influenzare la stessa area dell’orientamento coinvolta nella meditazione profonda e quindi di favorire l’esperienza del sacro (capitolo V), il testo si fa maggiormente propositivo, e quindi dibattibile, a partire dal capitolo VI quando gli autori avanzano un’ipotesi propriamente neuroteologica intorno al misticismo.
Il misticismo quale fondamento della fede religiosa
Contrapponendosi frontalmente a quella che nel testo è definita l’interpretazione maggioritaria del fenomeno del misticismo da parte dei contemporanei psicologi e psichiatri, secondo cui tale esperienza è frutto di stati allucinatori, stress psichico o semplicemente malattie mentali, gli autori fanno più volte riferimento, nella loro spiegazione, ad un concetto di ‘reale’ un po’ sfuggente nella sua definizione: «In base alle nostre ricerche, ci sentiamo autorizzati a concludere che esperienze mistiche sincere come quella, per esempio, di Margareta Ebner non siano sempre il risultato di angosce emotive, illusioni nevrotiche o stati patologici, ma, anzi, siano il prodotto di menti sane e normali che reagiscono in maniera coerente a percezioni perfettamente reali in termini neurologici. La neurobiologia dell’esperienza mistica ci autorizza a pensarlo» (p. 104). L’espressione ‘percezione perfettamente reale’, di per sé, non appare propriamente pacifica, in quanto ogni percezione è soggettiva, e l’aggiunta che si tratti di percezione reale ‘in termini neurologici’ non aiuta molto a chiarificare il concetto.
Gli autori spiegano il loro significato di ‘esperienza mistica’, chiamata indistintamente ora estasi, ora nirvana o atman brahminico. Nella loro accezione, l’esperienza mistica è la condizione raggiunta dal soggetto quando “la mente esiste senza l’io” (p. 122), ovvero quando ci siamo elevati ad uno stato di unità con il Tutto che non è turbato da pensieri o sensazioni individuali. Gli autori risultano meno precisi quando si spingono a discutere la realtà di una tale condizione. In maniera probabilmente consapevole, inanellano una serie di considerazioni altalenanti, molto attenti a non urtare la sensibilità né dei materialisti né degli spiritualisti. Poco dopo aver affermato la realtà della percezione mistica, gli autori si premurano di sottolineare che questo, tuttavia, «non dimostra in alcun modo l’esistenza di una realtà spirituale assoluta» (p. 128), anche se, nel gioco dei contrappesi, subito postillano che non intendono «certo escludere che sia qualcosa di più di una funzione neurale» (ib.). E questo ‘di più’ si espone fino al riconoscimento scientifico «che esperire l’essere unitario assoluto, ossia realizzare l’antica unio mystica, sia un fenomeno concreto e reale quanto qualsiasi altro» (p. 162). E il dubbio insorge di nuovo intorno al significato che gli autori intendono assegnare al concetto di ‘realtà’: parlare in maniera indistinta di ‘realtà fenomenica’, ‘realtà mistica’, ‘realtà mentale’ e ‘realtà metafisica’, e senza definizione seppur sommaria delle differenze sfocia inevitabilmente il concetto stesso di ‘realtà’. (Il titolo del capitolo VIII – “Più reale del reale” – riesce solo ad elevare il dubbio alla potenza!)
La seconda metà del libro è dedicata interamente alla considerazione del ruolo ricoperto dall’esperienza mistica nella fondazione delle religioni. Gli autori controbattono puntigliosamente alle critiche classiche che i filosofi e gli psicologi atei hanno concepito. Replicano a Nietzsche, precisando che il Dio che egli definiva oramai morto era solo una caricaturale rappresentazione biblica che non ha nulla a che spartire con la loro “idea di una realtà mistica superiore” (p. 170). Contro la presa di posizione dell’American Psychiatric Association che fino al 1994 collocava le ‘forti convinzioni religiose’ tra i disturbi mentali da catalogare nel DSM-IV, gli autori parlano di un’incomprensione pregiudizievole e profonda del fenomeno (p. 133). Etichettano inoltre come “cinico giudizio” tutta l’impalcatura di pensiero del “materialistico razionalista” secondo cui la fede religiosa si basa solo sulla superstizione e sulla paura (p. 132). A fronte di tali incomprensioni, gli autori ribadiscono che, sulla base delle prove da loro rilevate, l’ipotesi più probabile è che «la religione affondi le radici nell’esperienza mistica» (ib.), la quale deve peraltro nascondere un vantaggio evolutivo, ovvero una qualche utilità pratica, che non è stata ancora appurata, ma che dovrebbe avvicinarsi alla funzione della sessualità, dato che i meccanismi neurali di trascendenza derivano dagli stessi circuiti nervosi che regolano le dinamiche sessuali.
L’intero flusso argomentativo vorrebbe confluire in una dimensione che gli autori vorrebbero ecumenica, anche se forse sarebbe più opportuno definire sincretica: quando i mistici raggiungono ‘lo stato unitario assoluto’ che costituisce il fondamento di ogni religione, a qualsiasi tradizione appartengano, essi esperiscono la medesima ed unica verità della quale non si danno versioni conflittuali o antagonistiche. I contrasti religiosi e gli scismi sorgono solo laddove il percorso mistico non è giunto al suo pieno compimento e i religiosi, bloccati su aspetti parziali e incompleti della verità, vogliono affermare i loro guadagni mostrando intolleranza nei confronti dei raggiungimenti altrui che non riescono a percepire. Laddove però la verità sia colta nella sua pienezza vigono soltanto armonia e condivisione.
Siamo all’ultima pagina. Gli autori si dicono soddisfatti delle varie congetture proposte e si congedano ribadendo quella “più affascinante di tutte”, ovvero l’ipotesi che «lo stato unitario supremo abbia una giustificazione razionale. Che l’essere unitario assoluto sia reale non dimostra in via definitiva l’esistenza di un Dio superiore, ma dà buoni motivi di credere che la vita umana assommi a qualcosa di più di una mera esistenza materiale. La nostra mente è istintivamente attratta da quella realtà profonda, da quello stato di totale unità in cui ogni dolore svanisce e ogni desiderio si placa. Finché il cervello sarà strutturato com’è, finché la mente riuscirà a cogliere un mondo trascendente, la spiritualità continuerà a forgiare l’esperienza umana e Dio - comunque definiamo quell’essere infinito e misterioso – non morirà» (p. 172). E in questo modo il ciclo del libro si chiude con le ultime parole che offrono la traduzione letterale del titolo che era andata perduta nella resa italiana.
Osservazioni critiche
In sede di commento è possibile notare come, a fronte di una prima parte di marca accentuatamente neuro-scientifica, ricca di informazioni intorno ai correlati neurali dell’esperienza religiosa, padroneggiate con sicurezza e competenza dagli autori, ecco che il libro propone una seconda parte maggiormente teorica e propositiva – in cui gradualmente prende corpo l’ipotesi del misticismo come fondamento esclusivo della fede, della spiritualità e della conoscibilità del divino– che presta il fianco a considerazioni anche critiche.
Se da un lato è infatti da apprezzare la serietà con cui gli autori indagano l’esperienza mistica ed anche l’originalità della prospettiva proposta, che non può che allargare la visuale sull’esperienza stessa, dall’altro lato, l’azzardata ipotesi che essi profilano li espone almeno a due pericoli di non lieve entità.
In primo luogo è da chiedersi se gli autori siano nella condizione di conoscere effettivamente il fenomeno su cui tanto a lungo discettano o, in termini più brutali, se sanno ciò di cui stanno parlando. Tra i tanti argomenti che la filosofia della mente ha fatto fiorire nel momento più caldo del proprio dibattito interno, alimentò molto clamore quello di Frank Jackson che sembra calzare perfettamente a questo proposito. L’argomento vede come protagonista l’immaginaria Mary di professione neurofisiologa. Mary, suggerisce Jackson, ha trascorso i suoi anni a studiare il funzionamento del cervello nella visione dei colori, pervenendo ad esiti che solo in futuro l’umanità potrà acquisire: sa tutto dell’articolazione cerebrale nell’atto di discriminare ed elaborare gli stimoli percettivi; conosce i singoli neuroni coinvolti nell’esperienza; sa che a quella particolare configurazione neurale equivale la percezione del colore rosso, l’altra alla percezione del giallo e così via. Mary, però, ha accumulato tali studi in uno strano ambiente: una stanza dove tutto è bianco e nero, senza mai uscirne. Ella conosce perfettamente, dunque, cosa corrisponde fisiologicamente all’esperienza della percezione di un colore, ma si può per questo affermare che conosce davvero i colori? (cfr. “Epiphenomenal Qualia”, Philosophical Quarterly, 1982, n. 32, 127-136). Lo stesso interrogativo – che spinge verso la risposta negativa –vale anche per i nostri due radiologi autori del libro. La distanza che intercorre tra il conoscere ciò che neurologicamente corrisponde a determinate esperienze soggettive (in termini propri ‘qualia’) e il conoscere l’esperienza medesima non è analogamente la stessa distanza che passa tra il leggere l’elenco degli ingredienti di una merendina e assaggiare la merendina stessa? Sulla logica di questa obiezione filosofica si basa, per di più, anche un’obiezione peculiarmente teologica. Laddove infatti la filosofia avverte dell’inesaustività della descrizione scientifico-quantitativa per la conoscenza di un’esperienza soggettiva, ecco che la teologia avverte dell’inesaustività della descrizione scientifico-naturalistica per la conoscenza di ogni esperienza soprannaturale. Si tratta peraltro di una nota metodologica alla quale Newberg e D’Aquili si appellano esplicitamente (cfr. p. 104), per poi però soprassedervi nel concreto.
Una seconda obiezione critica di rilievo riguarda l’ipotesi degli autori secondo cui il misticismo costituisce l’esclusivo fondamento della religione. Riconoscere l’importanza del suo ruolo nell’esperienza religiosa è certamente positivo, ma assegnare ad esso l’esclusività significa ridimensionare o addirittura ignorare altri aspetti che invece sono essenziali, come il dato rivelato, la dimensione ecclesiale-comunitaria, la componente liturgico-sacramentaria e la dimensione supereminente dell’amore/charitas.
Tali osservazioni critiche, che potrebbero essere accompagnate da varie altre, non annullano certo il valore della ricerca di Newberg e D’Aquili, che ha il merito di stimolare la riflessione in questo ordine di temi e di offrire una prospettiva originale che arricchisce senza dubbio il quadro d’insieme.
Sviluppi successivi della neuroteologia
Mentre Newberg ha confermato il suo ruolo di porta vessilli della neuroteologia, con testi (non tradotti in italiano) come Principles of Neurotheology (2010), How God Changes Your Brain(2010), God and the Brain (2015) e Neurotheology (2018), nel corso degli anni, le indagini in questo settore si sono moltiplicate e, grazie a tecniche di neuroimaging sempre più sofisticate, è stata raccolta una messe di dati molto abbondante. Dalla pubblicazione di Why God Won’t Go Away è possibile individuare, cronologicamente, tre filoni di ricerca.
Nel primo decennio del Duemila si è fondamentalmente proseguito il sentiero di Newberg e D’Aquili sui correlati neurali della meditazione. Le riviste neuro-scientifiche del periodo hanno proposto generosamente titoli come Neural correlates of religious experience(Azari et al., 2001), Meditation states and traits: EEG, ERP, and neuroimaging studies (Cahn et al., 2006), Neural correlates of a mystical experience in Carmelite nuns, (Beauregard-Paquette, 2006), Neural correlates of attentional expertise in long-term meditation practitioners(Brefczynski-Lewis et al., 2007),che hanno portato in evidenza il collegamento tra differenti tecniche meditative e specifiche aree cerebrali, nonché la capacità della meditazione di modificare talune funzioni cognitive (Lutz et al,. Regulation of the neural circuitry of emotion by compassion meditation: effects of meditative expertise, 2008). A questa area possono essere riportati anche gli studi sulle accertate influenze positive della preghiera e della disciplina interiore nell’affrontare determinate malattie e, più in generale, situazioni di stress e dolore (Schjoedt et al., Rewarding Prayers, 2008).
Successivamente, intorno alla fine del primo decennio, l'attenzione della ricerca neuroteologica ha mutato obiettivo e si è rivolta ai contenuti della credenza, per verificare un’ipotizzata differenza di configurazione cerebrale tra credenti e atei. Studi come The neural correlates of religious and nonreligious belief e Functional neuroimaging of belief, disbelief, and uncertainty di Sam Harris et al. (2009) o Cognitive and neural foundations of religious belief di Kapogiannis et al. (2009) hanno indagato possibili differenze, a livello sinaptico, tra la fede della persona religiosa e le convinzioni dell'ateo, ovvero se la fede nell'immortalità dell'anima o nella nullificazione totale, nel Caso o nel Logos, appartenessero a regioni cerebrali specifiche, magari maggiormente sviluppate nell’un caso o nell’altro. La ricerca sull’area della fede in Dio non ha fornito però i dati sperati. Le rilevazioni di simili studi hanno infatti dimostrato che l’attività cerebrale della credenza è content-indipendent: la comparazione di neuroimaging e elettrofisiologia tra persone di diverso orientamento che esprimono giudizi su determinati contenuti di credenze, aderendovi o rigettandole, attivano la medesima area della corteccia ventro-mediale prefrontale, senza differenze rilevabili.
La fase più recente della ricerca, infine, va in realtà a intersecare gli ambiti della neuroscienza e della psicologia cognitiva. Ad accendere la scintilla che ha provocato non poco clamore sono stati due studi del 2012/13 di Ara Norenzayan e Will Gervais della British Columbia University: Analytic thinking promotes religious disbelief, pubblicato su “Science” e The origins of religious disbelief, in “Trends in Cognitive Sciences”. La tesi dei due autori, avvalorata da abbondanti evidenze sperimentali, sostiene che l'esercizio privilegiato del pensiero analitico produce un'abitudine cognitiva e un corrispondente quadro neurologico che favorisce l'ateismo e addirittura indebolisce la fede dei credenti. Essendo l’intelligenza analitica quella privilegiata nei test di misurazione del Quoziente Intellettivo non è stato difficile per certi autori dall’accentuata vis polemica e provocatoria concludere che gli atei sono più intelligenti dei credenti. Gli studi di Gordon Pennycook et al., Analytic cognitive style predicts religious and paranormal belief (2012) e Atheists and agnostic are more reflective than religious believers (2016) procedono su tale sentiero d’interpretazione. Non si è fatta attendere la risposta con studi che hanno accreditato i dati, ma non la conclusione (C.-C. Liu, The relationship between personal religious orientation and emotional intelligence, 2010; A. Shenav et al., Divine intuition: cognitive style influencesbelief in God, 2012; P. Valdesolo et al., Awe, incertainty, and agency detection, 2014): la fede religiosa non è collegata ad un maggiore o minore quoziente intellettivo, anche se è associata a un determinato stile di intelligenza, per cui i soggetti con una marcata propensione per uno stile analitico di pensiero abbracciano più difficilmente un credo religioso, a differenza dei soggetti con un’intelligenza più accentuatamente emotiva o sintetica che, invece, hanno maggior facilità nell’intuire i tratti del disegno divino nel mondo in cui vivono.