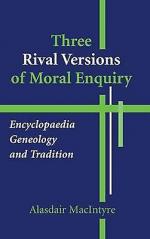Alasdair MacIntyre è certamente uno dei più importanti filosofi di marca anglosassone ad avere riproposto il valore della prospettiva aristotelica e tomista, non solo quale dottrina morale, ma ancora più a fondo come efficace modello di razionalità.
Si può certamente osservare una sorta di traiettoria, che egli ha percorso durante gli anni Ottanta del Ventesimo secolo per raggiungere e consolidare questa consapevolezza. Al fortunato Dopo la virtù, del 1981, è seguito Giustizia e Razionalità del 1988, in cui MacIntyre ha messo a fuoco una nozione decisiva nell’articolazione del suo pensiero: quella di «tradizione». Infatti, MacIntyre intende sottolineare che la razionalità non si esercita assumendo una posizione astrattamente imparziale, bensì all’interno di una precisa tradizione di pensiero, che si misura con altre tradizioni rivali nella determinazione delle proprie ricerche e nella modalità in cui si rende ragione di esse. Enciclopedia, Genealogia e Tradizione. Tre versioni rivali di ricerca morale si trova come al culmine di questa traiettoria, in cui MacIntyre consolida la propria posizione nei confronti di due punti fondamentali, già presenti negli scritti precedenti. Il primo riguarda l’accusa di relativismo: se ogni esercizio della razionalità avviene all’interno di una tradizione, come sarà possibile sviluppare una genuina pretesa veritativa? Il secondo punto riguarda la sempre più chiara opzione per il tomismo, che MacIntyre stava maturando in quegli anni. In quest’opera egli articolerà un percorso in cui emergerà in quale modo il tomismo vada considerato oggi la versione di razionalità e di ricerca morale capace di superare le unilateralità e le debolezze delle posizioni rivali.
Enciclopedia e Genealogia
L’occasione per redigere quest’opera viene dal fatto che MacIntyre ha tenuto nel 1988 le prestigiose Gifford Lectures. Lord Adam Gifford (1820-1887) aveva infatti disposto un lascito alle università scozzesi di Edimburgo, Glasgow, St. Andrews e Aberdeen, per sponsorizzare conferenze e lezioni che avessero come scopo quello di promuovere e diffondere lo studio della teologia naturale e dei fondamenti dell’etica. Così, nel primo capitolo del volume, MacIntyre esamina lo spirito con cui Lord Gifford aveva istituito queste lectures, di cui cadeva in quell’anno il centenario, sottolineando che egli assumeva quello stesso spirito che stava alla base della Nona edizione dell’Encyclopedia Britannica e che aveva la sua matrice nell’enciclopedia francese di Diderot e d’Alembert.
Quello dell’«enciclopedia» è in effetti il primo dei tre modelli fondamentali che secondo MacIntyre caratterizzano il nostro modo di concepire la razionalità e la ricerca morale. In virtù della propria radice Illuministica, il modello enciclopedico esige l’adozione di un «unico concetto sostantivo di razionalità» (p. 52), che tutti gli uomini colti avrebbero condiviso e che si ottiene prescindendo da qualsiasi appartenenza comunitaria, sociale, politica, religiosa. Secondo l’enciclopedista, la ragione è universale, precisamente in quanto separata dalle concrete pratiche vitali ed esistenziali degli uomini che la utilizzano. Essa potrà quindi apparire adeguata solo separandosi dai percorsi personali, dalle tradizioni o dalle religioni positive professate da chi ricerca, parla o scrive. Ciò conduce l’enciclopedista a ritenere che la morale sia costituita in larga parte da un insieme di regole codificate, di doveri a cui bisogna universalmente obbedire. Inoltre, tipico della mentalità enciclopedista è un certo senso di superiorità rispetto al passato, concepito, in maniera piuttosto unitaria e omogenea, come luogo in cui sono sorte versioni più rozze e più primitive di quella che l’enciclopedista stesso avrebbe poi assunto, grazie ad un uso più proprio della ragione.
MacIntyre osserva anche che questo modo di intendere la ricerca morale implica che l’enciclopedista identifichi l’universalità della ragione con il proprio modo particolare di pensare. Non è un caso che l’enciclopedista tenda a leggere ciò che accade nelle altre culture alla luce dei propri schemi mentali. Un esempio di questa attitudine si troverebbe nel modo in cui nella Nona edizione dell’Enciclopedia Britannica è trattato il tema del tabù presso le popolazioni polinesiane. L’enfasi sulla dimensione proibitiva e repressiva del tabù non è proprio del tabù stesso, ma dipende dal fatto che esso sia stato letto secondo gli schemi morali propri dell’enciclopedista: era lui, più che il polinesiano, a mettere in primo piano la proibizione e l’interdizione.
Quello che MacIntyre chiama «Genealogia» è invece il modello di razionalità e di ricerca morale che trova le proprie basi nella filosofia di Friedrich Nietzsche e che è stato adottato da quegli intellettuali come Michel Foucault o Gilles Deleuze. Mentre il metodo illuministico dell’enciclopedia ritiene che esista un uso universalmente valido della ragione che dipende dall’imparzialità, ossia del fatto di prescindere da ogni prospettiva particolare, il metodo genealogico intende mostrare all’inverso che non esiste alcuna verità unica, bensì solo sguardi prospettici, espressioni di punti di vista particolari. Inoltre, il genealogista si impegna a smascherare la cattiva coscienza, le deformazioni psicologiche, l’inconfessato risentimento che si nascondo dietro l’ideale di ragione e di moralità coltivato dall’enciclopedista. Così la genealogia si costituisce come pratica di decostruzione di ogni struttura concettuale che evochi qualcosa di fisso e universale: la morale, la religione, l’identità stessa dell’io.
Identificandosi in un’azione di continuo smascheramento e rifiutando tutto ciò che implica riferimenti stabili e fissi, il genealogista, secondo MacIntyre, si trova a lottare continuamente contro il rischio dell’auto-confutazione. Per essere coerente fino in fondo con la propria stessa opera di decostruzione, il genealogista dovrebbe abolire ogni «tradizionale» riferimento alle pratiche accademiche e all’abituale struttura del discorso argomentativo, mentre invece si serve del discorso, scrive articoli e libri in cui vengono fatte valere la grammatica e quella elementare «metafisica della lettura», secondo la quale l’egodell’autore e quello del lettore mantengono una certa stabilità, tale da permettere loro di mettersi in relazione l’uno con l’altro. Inoltre, se per coerenza Nietzsche si è sentito in dovere di uscire dal mondo accademico per esprimere la propria visione della realtà, i genealogisti non disdegnano affatto di entrarvi e diventarne celebrate autorità, come nel caso di Foucault. «Il problema del genealogista – scrive MacIntyre – diventa allora quello di dovere conciliare l’immobilità di particolari atteggiamenti quali si riscontra nei generi di produzione scritta e orale con la mobilità richiesta dal passaggio da un atteggiamento all’altro, di come assumere i contorni di una determinata maschera per poi liberarsi a favore di un’altra, senza rischiare di restare coinvolto nella finzione metafisica di un volto che abbia la propria verità e la propria insostituibile rappresentazione. […] Ma tutto ciò è veramente possibile?» (p. 83).
L’enciclopedista, però, non riesce a trarre vantaggio da queste auto-confutazioni del genealogista, perché lo smascheramento operato dai genealogisti circa i presupposti morali, metafisici e teologici della cultura da cui l’enciclopedismo proviene appaiono effettivamente convincenti. Prova ne è, secondo MacIntyre, il fatto che le edizioni dell’enciclopedia successive alla Nona si sono decisamente allontanate da quel progetto illuministico, risultando oramai una serie frammentaria di contributi eterogenei e tra loro divergenti.
Tomismo o Tomismi?
Di fronte alla dicotomia tra la visione illuministica-enciclopedica – che assume un’idea di ragione impersonale, imparziale, e per questo unificatrice e universale – e quella genealogica, che promuove invece una visione prospettica della verità, insieme all’estrema fluidità delle posizioni e dell’io stesso che dovrebbe assumerle, MacIntyre osserva che esiste una terza via, secondo la quale la particolarità della condizione storico-esistenziale del ricercatore e l’universalità della verità non sono in conflitto; una terza via secondo la quale non si può tentare di avvicinarsi alla verità senza possedere precise virtù morali e intellettuali, che si vivono nella comunità politica e filosofica. Secondo questa terza via, dunque, non si può sviluppare un efficace modello di razionalità senza un personale impegno preliminare, che non neghi ostinatamente – come fanno gli enciclopedisti – il fatto che esistano, su tutti gli argomenti importanti, posizioni rivali e irriducibili; nemmeno però intende fermarsi a questa irriducibilità, come fanno i genealogisti, ma si assume il compito di misurarsi con esse dialetticamente, impegnandosi ad individuare gli elementi di inadeguatezza delle diverse posizioni rivali, generando un percorso storico di discussione.
MacIntyre intende mostrare nei capitoli centrali del libro che questa terza via è rappresentata dal tomismo: Tommaso d’Aquino ha infatti saputo valorizzare il modo in cui i greci, in particolare Aristotele, avevano concepito la sapienza, ponendolo in una sintesi feconda con il pensiero biblico e la tradizione agostiniana. All’interno di questa tradizione si realizza un certo modo di concepire la filosofia che risale al Gorgia e alla Repubblica, secondo il quale «se si vuole arrivare a una conoscenza della verità sul proprio bene e sul bene caratteristico di ogni uomo, bisogna imparare a trasformarsi in un nuovo tipo di persona» (p. 99).
Per fare questo bisogna apprendere un’arte, una techne: come l’artigiano, anche il filosofo deve imparare il «mestiere» di conoscere, assumendo gradualmente la capacità di applicare i migliori criteri alla soluzione delle diverse domande che si pone, per ottenere i migliori risultati; egli impara anche, come fa appunto il miglior artigiano, a riconoscere quali disposizioni sono le più adatte per raggiungere il fine della propria arte. Nel fare tutto questo, è cruciale la posizione del maestro: è necessario che vi sia qualcuno che, in virtù dell’autorità che si è guadagnata sul campo, indichi agli apprendisti i comportamenti migliori – in tal caso i migliori atteggiamenti morali e intellettuali – grazie ai quali l’apprendista impara a partecipare in modo autonomo all’impresa della ricerca. «Da qui emerge – scrive MacIntyre – una concezione di autorità razionale docente, interna all’esercizio della pratica, del mestiere della ricerca morale, proprio come succede in altri mestieri, come l’artigianato dei mobili della pesca, dove al pari della ricerca morale, questa concezione definisce in maniera significativa rapporto tra il maestro apprendista. Queste idee sono evidentemente in aperto contrasto con l’etica sia dell’Enciclopedia che della Genealogia. Gli enciclopedisti infatti avevano imparato da Kant che per essere razionali era necessario sottrarsi alla tutela di ogni autorità. L’idea che io possa pensare in modo adeguato da solo e grazie alle mie capacità soltanto nella misura in cui lo faccio in compagnia di altri, ad alcuni dei quali è attribuita una autorità, è totalmente assurda inconcepibile per l’enciclopedista così come lo è per il genealogista, che non sanno vedere in tale autorità altro che l’esempio di un potere oppressivo a cui si deve resistere a tutti costi, fino la ribellione» (p. 104).
In tale quadro, non dovrebbe esserci difficoltà nell’accettare il fatto che, condiviso il fine dell’arte o tecnica, possano esserci versioni imperfette, parziali o rivali e che sia all’interno della storia di questa pratica che ogni singolo contributo può correggere o migliorare quanto raggiunto. Così, l’unità della verità non sta nell’individuazione di conclusioni ottenute con un ragionamento che fin dall’inizio e a prescindere dovrebbe avere tutte le caratteristiche richieste. Nel modello di cui il tomismo si fa portavoce, la tradizione svolge un ruolo, quale via verso la sempre migliore determinazione della verità. Secondo questa prospettiva, il passato non rappresenta né qualcosa da mitizzare, né ciò da cui prescindere, né tantomeno il luogo in cui ritrovare le deviazione da smascherare. Piuttosto, concependo la filosofia come un’arte, che fa tesoro di ciò che ha prodotto storicamente, la versione tomista permette di comprendere come sia all’interno di un percorso storicamente individuato che si mira alla formulazione di una verità che vada oltre i confini del qui e dell’ora: ciò è possibile nella articolazione di una serie di riformulazioni successive, passate e ancora a venire. In tal modo, sia la funzione dell’autorità docente, sia la relazione con il passato assumono tutto il loro significato: «è proprio sapendo come fare a leggere il passato e il presente che chi esercita l’autorità sa appoggiarsi alla tradizione per interpretarla e reinterpretarla, in modo che il movimento verso il raggiungimento del telos in quel particolare mestiere sia caratterizzato continuamente in forme nuove e insospettate. L’abilità di insegnare ad altri come raggiungere questa conoscenza è ciò che fa dell’influenza del maestro un’autorità legittimata come razionale, all’interno di una comunità che esercita un mestiere» (p. 107).
MacIntyre prende atto del fatto che esistano diverse versioni contemporanee di tomismo. Ciò è accaduto, a suo avviso, perché non sempre si è guardato ad esso per quello che è, ma si è cercato di leggere Tommaso secondo esigenze filosofiche e concettuali estranee ed estrinseche, come il bisogno di confrontarsi con il kantismo (Rosmini o Maréchal), di misurarsi con l’ambiente accademico francese (Rousselot), oppure con la dottrina dei diritti umani che anima le Dichiarazioni internazionali dei diritti (Maritain). Ben diverso – e più positivo a suo avviso – è invece l’approccio di quegli studiosi (come Grabmann, Gilson o Van Steenberghen), che invece hanno cercato di ricostruire il pensiero di Tommaso nella sua forma primigenia, «sfidando i canoni moderni della ricerca morale e teologica, e in contrapposizione dichiarata ai tomisti sistematici, che non facevano altro che moltiplicare indefinitamente i disaccordi» (p. 121). MacIntyre affianca all’autorità di Tommaso quella di Dante nella capacità di proporre una linea di ricerca morale efficace secondo questo tipo di tradizione.
Nei capitoli quarto e quinto MacIntyre cerca di mostrare come Aristotele e sant’Agostino abbiano dato vita a due tradizioni di ricerca rivali, che hanno trovato nella nascita dell’università medievale un luogo in cui venire messe in relazione. Nel sesto capitolo si concentra su Tommaso d’Aquino e osserva come quest’ultimo abbia saputo elaborare un modello di ricerca in cui la filosofia teoretica e quella pratica si intrecciano e si arricchiscono l’un l’altra, così come l’attività di ricerca e quella di insegnamento; inoltre, la pratica filosofica appare strutturata secondo una serie di discipline dotate ciascuna di propria autonomia e peculiarità, ma anche in relazione tra loro, secondo una certa gerarchia e subordinazione di alcune rispetto alle altre. In tale quadro, anche la teologia trova un posto come disciplina filosofica, generando un programma di studi che permette di porre all’interno delle stesse strutture argomentative sia la dottrina di san Paolo che quella aristotelica.
MacIntyre sottolinea anche il fatto che, nella Summa Theologiae, Tommaso affronti certamente una serie di temi tra loro diversi, ma senza l’idea di trattarli come tematiche separate, avulse da un contesto unitario di riferimento. Quanto alla filosofia morale, è chiaro che Tommaso d’Aquino parte dalla ricerca del bene dell’uomo, che però non è univoco, ma consta di aspetti diversi. Così, l’etica di Tommaso non assomiglia affatto ad un insieme razionalistico di deduzioni dal primo principio «fai il bene, evita il male», ma dalla capacità di mettere questo principio in relazione con la molteplicità di tratti e dimensioni che caratterizzano l’esistenza concreta, capacità che matura nel confronto con gli altri membri appartenenti alla nostra comunità. Così, gli stessi principi della legge naturale, su cui si è certamente diretto gran parte dell’interesse per l’etica di Tommaso d’Aquino in ambito anglosassone, non sono principi astratti, come nel caso illuministico, ma emergono da un confronto con l’educazione ricevuta dai genitori, con le leggi e regole sociali che troviamo nella comunità. Inoltre, Tommaso non manca di mostrare che il bene ultimo dell’uomo si trova nel rapporto dell’anima con qualcosa che sta fuori di essa e con un genere di bene che trascende l’ordine mondano. MacIntyre precisa che, parlando in questo modo, Tommaso non si limitava ad affiancare la Scrittura o sant’Agostino ad Aristotele, ma «stava cercando di essere un miglior aristotelico di quanto fosse stato Aristotele stesso» (p. 197). L’idea aristotelica secondo cui la felicità sta nella contemplazione intellettuale, infatti, senza un riferimento concreto al bene ultimo divino sarebbe condannata ad un’insoddisfazione permanente. In tale contesto, Tommaso non pone in contrapposizione norme e virtù, ma mostra che l’applicazione delle norme fa parte dell’esercizio stesso delle virtù e così le prescrizioni negative, spesso presenti nelle norme esprimono una determinazione soltanto parziale del tipo di bontà a cui dovremmo mirare, perché hanno un compito importante ma limitato, ossia quello di segnare i confini della vita buona. La convinzione che la dottrina di san Paolo, quella di Agostino e quella di Aristotele abbiano un nucleo fondamentale comune, che merita di essere sviluppato, è ciò che rende il tomismo fecondo circa la possibilità di far sorgere una relazione costruttiva tra filosofia e teologia. La coscienza di essere creature e di essere responsabili del male deliberato non è indifferente alla buona pratica filosofica, perché ci mette nella condizione di essere umili, atteggiamento questo che manca nelle versioni rivali di ricerca morale.
Ripensare l’università come «luogo di dissensi forzati»
Negli ultimi capitoli MacIntyre offre una riflessione articolata su come l’università possa e debba ancora essere considerata il luogo privilegiato in cui svolgere una genuina ricerca in filosofia morale, articolando un valido modello di razionalità. Nel fare questo, MacIntyre intende mostrare che l’istituzione universitaria, a partire dal quattordicesimo e dal quindicesimo secolo, non ha consolidato la prospettiva tomista. Al contrario, sotto l’egida di Scoto e di altri autori non tomisti, si è allontanata da una pratica che favoriva lo svolgimento di una ricerca che faceva unità nella varietà e nella eterogeneità. L’esito di questo abbandono ha portato a fare della filosofia accademica una disciplina organizzata e professionalizzata. Di questo tratto si sarebbe alimentata l’università moderna, nella quale si è via via imposta la convinzione che l’unico progresso che si può riconoscere è quello che riguarda l’abilità, il metodo e la tecnica nel formulare i problemi.
Chiariti questi punti, MacIntyre svolge una interessantissima riflessione sul senso e sui compiti dell’istituzione universitaria, in particolare nel decimo capitolo, intitolato Ripensare l’università come istituzione elezione come genere accademico. In queste pagine, MacIntyre mostra come l’attuale sistema universitario si trovi in una crisi di identità che parte da lontano e che potrebbe essere risolta solo recuperando la pratica accademica tipica del tredicesimo secolo, quella stessa che caratterizzava l’insegnamento e l’opera di san Tommaso. In quel tipo di pratica, infatti, l’università è precisamente il luogo in cui si impara a misurarsi adeguatamente con la presenza di posizioni rivali: nella lezione medievale, infatti, si era già sempre consapevoli che la presenza e la discussione di posizioni rivali fosse parte integrante del percorso di insegnamento e di ricerca; inoltre, la perizia tecnica non era fine a se stessa, ma restava ancorata ad un esercizio, ad un’«arte» che ne dettava il senso e i confini. Nell’università attuale, divisa invece tra un dissenso considerato ormai insanabile e un’esaltazione delle discipline – e delle competenze – di tipo tecnico, l’autentica ricerca in filosofia morale, concernente il bene più alto dell’uomo, è lasciata ad un sostanziale soggettivismo. Questo però genera un vulnus fatale, secondo MacIntyre: «l’università come istituzione può venire giustificata soltanto ricorrendo a una qualche specifica spiegazione razionale del modo in cui i beni per l’uomo debbano essere ordinati, e alla definizione dell’importanza da attribuire ai beni della ricerca all’interno di questo ordine». Perciò, prosegue subito dopo, «l’assenza dall’università di ogni forma di ricerca razionale che offra una spiegazione sistematica del modo in cui i beni debbano venire ordinati impedisce all’università di rispondere in modo adeguato ai suoi critici esterni. Di conseguenza, l’incapacità degli universitari e dei college di dare risposte non risiede nell’incapacità dei singoli. La futilità e la trivialità di così tanta retorica accademica ufficiale è sintomo di un disordine molto più profondo» (p. 316).
In virtù di tali premesse, MacIntyre illustra una delle sue tesi più significative, che ha mantenuto e difeso nel corso della propria carriera: il migliore sviluppo della razionalità ha bisogno di un luogo che si costituisca precisamente come un «teatro di conflitti in cui venga riconosciuto anche il genere di dissenso morale e teologico più radicato» (p. 323); di un luogo insomma in cui le posizioni rivali vengano espresse adeguatamente, garantendo che la parte rivale non venga soffocata in maniera illegittima o con la forza. In una università simile, chi insegna e chi fa ricerca non dovrebbe temere di rappresentare una posizione ben precisa. Piuttosto, a partire da essa, dovrebbe essere in grado di intavolare una discussione proficua, misurandosi con le debolezze dell’altro e ripensando, ad un tempo, la consistenza della propria posizione. «In un’università come io l’ho ripensata – scrive MacIntyre al termine della sua trattazione – compito fondamentale del conferenziere, quando si occupi in qualche modo di problemi di giustificazione razionale […] resta quello di fare in modo che almeno una gran parte del suo pubblico dissenta, e di spiegare loro perché siano costretti a dissentire e che cosa sia tipico del loro stato che garantirebbe questo dissenso» (pp. 322-323). Questa è dunque la proposta finale di MacIntyre: ridare all’università la sua identità di «luogo di dissensi forzati», alla cui riattualizzazione il tomismo darebbe il proprio contributo, in quanto «comporterebbe una riconferma delle forme tipiche del tredicesimo secolo, ma con i contenuti del ventesimo» (p. 323).