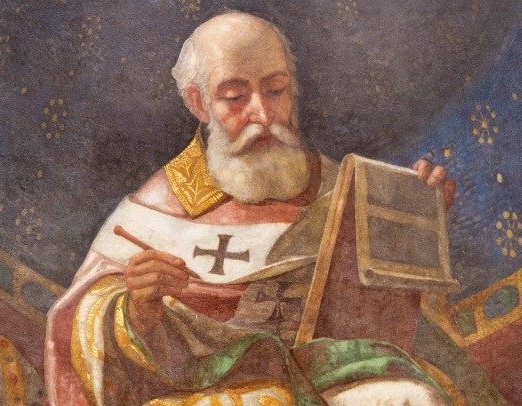[Università Cattolica "Nuestra Señora de la Asunción" (Paraguay), 8-10 ottobre 2025]
Cari fratelli e sorelle,
Desidero innanzitutto rivolgere il mio saluto a Sua Eccellenza Reverendissima mons. Francisco Javier Pistilli Scorzara, P. Sch., Gran Cancelliere dell’università cattolica Nuestra Señora de la Asunción, e a tutti gli organizzatori e partecipanti a questo congresso internazionale che si propone di analizzare il ruolo e il significato del pensiero filosofico cristiano nella configurazione culturale del continente, al fine di illuminare, partendo dalla fede, le sfide contemporanee.
Con il congresso cercate di essere uno spazio di “incontro, diagnosi, dialogo e proiezione”. Cercare l’incontro è un proposito lodevole, che si oppone alla tentazione di quanti hanno visto nella riflessione razionale — poiché sorta in ambito pagano — una minaccia che avrebbe potuto “inquinare” la purezza della fede cristiana. Pio XII, nell’enciclica Humani generis, metteva in guardia contro l’atteggiamento di quanti, pretendendo di esaltare la Parola di Dio, finivano per sminuire il valore della ragione umana (n. 4). Questa sfiducia verso la filosofia si percepisce anche in alcuni autori moderni, come il teologo riformato Karl Barth. Di fronte a ciò, sant’Agostino ricordava: “Chiunque dunque ritiene che la filosofia si deve evitare in senso assoluto, pretende semplicemente che noi non amiamo la saggezza” (De ordine, I, 11,32). Pertanto, il credente non dovrebbe restare distante da ciò che propongono le diverse scuole filosofiche, ma entrare in dialogo con esse a partire dalla Sacra Scrittura.
In tal modo, il pensiero filosofico diventa uno spazio di incontro privilegiato con quanti non condividono il dono della fede. So per esperienza che l’incredulità è solitamente legata a una serie di pregiudizi storici, filosofici e di altro genere. Senza ridurre la filosofia a un mero strumento apologetico, è immenso il bene che un filosofo credente può compiere con la sua testimonianza di vita e con quello a cui ci incoraggia l’apostolo Pietro: «adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi» (1 Pt 3, 15).
Il secondo proposito, la diagnosi, ci permette di smascherare la pretesa di raggiungere la conoscenza trascendente attraverso la mera analisi razionale, al punto da confondere i beni propri di una vita “secondo ragione” con quelli che possono giungerci solo per grazia divina. Nell’Antichità, il monaco Pelagio sosteneva che bastava la volontà umana per adempiere ai comandamenti senza l’indispensabile aiuto della grazia, tesi a cui sant’Agostino rispose in modo tanto completo quanto profondo. Nella Modernità, G.W.F. Hegel, con la sua speculazione sullo “spirito assoluto”, finì col subordinare la fede al dispiegarsi razionale dello spirito. In diversi pensatori si scopre la stessa illusione, ossia il pensare che la ragione e la volontà bastino da sole per giungere alla verità.
Non dobbiamo dimenticare che la filosofia, essendo un arduo compito dell’intelligenza umana, può ascendere a vette che illuminano e nobilitano, ma può anche discendere a oscuri abissi di pessimismo, misantropia e relativismo, là dove la ragione, chiusa alla luce della fede, diventa ombra di sé stessa. Non tutto ciò che si riveste del nome di “razionale” o “filosofico” possiede in sé identico valore: la sua fecondità si misura in base alla sua conformità con la verità dell’essere e alla sua apertura alla grazia che illumina ogni intelligenza. Con genuina empatia verso tutti, dobbiamo offrire il nostro contributo affinché il nobile compito del filosofare riveli di più e meglio la dignità dell’uomo creato a immagine di Dio, la chiara distinzione tra il bene e il male, e l’affascinante struttura del reale che conduce al Creatore e Redentore.
Il passo successivo è fondamentale: il dialogo. Questo si è rivelato straordinariamente fecondo per i grandi pensatori, teologi e filosofi cristiani. Essi hanno dimostrato come la razionalità umana sia un dono espressamente voluto dal Creatore e come la ricerca più profonda della nostra intelligenza tenda verso la sapienza, che si manifesta nella creazione e raggiunge il suo culmine nell’incontro con nostro Signore Gesù Cristo, che ci rivela il Padre. In questa ottica, già riconoscibile nel II secolo in san Giustino, filosofo e martire, e proseguita poi in figure tanto eminenti come san Bonaventura o san Tommaso d’Aquino, si mostra che la fede e la ragione non solo non si oppongono, ma che si sostengono e completano anche in modo ammirevole. Come diceva il mio predecessore, san Giovanni Paolo II, «il legame intimo tra la sapienza teologica e il sapere filosofico è una delle ricchezze più originali della tradizione cristiana nell’approfondimento della verità rivelata» (Fides et ratio, n. 105).
Il pensatore cristiano è chiamato a essere un promemoria vivente dell’autentica vocazione filosofica come ricerca onesta e perseverante della Sapienza. In tempi in cui tante cose, e anche le persone stesse, vengono viste come scartabili, e in cui il moltiplicarsi dei progressi tecnologici sembra lasciare nella penombra i problemi più trascendenti, la filosofia ha molto da questionare e molto da offrire, nel dialogo tra fede e ragione e Chiesa e mondo.
Infine, la proiezione ci viene proposta come compito nel campo d’intersezione tra filosofia e fede. Senza dubbio, la filosofia, più per le sue domande che per le sue riposte, ci permette di analizzare il nucleo dei valori e i difetti presenti in ogni popolo. In questa linea, il lavoro dei filosofi credenti non può limitarsi a proclamare, pur se in un linguaggio elaborato, ciò che è esclusivo della propria cultura. La cultura, in tal senso, non può essere il fine. Sant’Agostino afferma che non si deve amare la verità perché la si è conosciuta attraverso questo o quel sapiente o filosofo, «ma perché è la verità, anche se nessuno di quei filosofi l’avesse mai conosciuta» (Lettera a Dioscoro, 118, IV, 26). Al contrario, è necessario che, senza perdere di vista le ricchezze culturali, questi pensatori ci aiutino a situarle nell’insieme delle grandi tradizioni di pensiero; in tal modo, il loro contributo sarà magnifico e se, inoltre, i vescovi, i sacerdoti e i missionari che sono chiamati a portare la Buona Novella saranno istruiti con questa conoscenza, il messaggio salvifico si trasmetterà con un linguaggio più comprensibile e pertinente per tutti.
Affidando al Signore il frutto dei vostri lavori, invoco su tutti voi la protezione dalla Beata Vergine Maria, Trono della Sapienza, e vi imparto la Benedizione apostolica come pegno di copiosi beni celesti.
Vaticano, 3 ottobre 2025