Festival dello spazio 2023 "Abitare lo spazio. Dalla terra alla luna e oltre"
Data del termine ultimo per la partecipazione al Concorso Festival dello Spazio 2023
In occasione della settima edizione del Festival dello Spazio di Busalla si indice un concorso a premi per un elaborato con la finalità di coinvolgere giovani impegnati negli studi universitari e nella ricerca che desiderano contestualizzare i loro studi o in un ampio quadro interdisciplinare, attento ai fondamenti umanistici, economici e sociali delle scienze spaziali.
Il progetto del concorso è stato messo a punto dall’Associazione Festival dello Spazio in collaborazione con la SISRI (Scuola Internazionale Superiore per la Ricerca interdisciplinare). È patrocinato da Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova e Comune di Busalla.
Gli elaborati vincitori saranno presentati dai loro autori al Festival dello Spazio 2023, in programma dal 29 giugno al 3 luglio, e sarà pubblicato nella documentazione elettronica e cartacea del Festival.
Il tema del concorso di quest'anno è “Abitare lo Spazio. Dalla Terra alla luna e oltre”. Il concorso è aperto a giovani di nazionalità Europea (stati membri UE ed ESA), di età non superiore ai 35 anni alla data del presente bando, in possesso di un diploma di livello universitario (almeno laurea triennale). L'elaborato dovrà essere inviato entro e non oltre il 7 maggio 2023 alla casella mail concorso@festivaldellospazio.com specificando nell’oggetto della email “Concorso Festival dello Spazio 2023"- Nome Cognome.
Il Premio per il vincitore consiste in un assegno di 1000,00 euro. Per gli altri due finalisti il premio consiste in un assegno di 250 euro per ciascuno. La proclamazione del vincitore/vincitrice avverrà in occasione del Festival 2023. A tutti e tre sarà data tempestiva comunicazione dell’esito affinché partecipino al Festival dello Spazio 2023 e presentino in pubblico il loro elaborato. Le spese di viaggio dei tre finalisti e la loro accoglienza a Busalla saranno a carico dell’Associazione Festival dello Spazio, ente organizzatore del Festival.
Vai al sito del Festival dello Spazio
Scarica il bando del regolamento
Con il riconoscimento delle virtù eroiche diventa venerabile padre Matteo Ricci, gesuita, apostolo nella Cina a cavallo tra il 1500 e il 1600, riconosciuto come uno dei più grandi missionari della Chiesa e tuttora venerato in Asia. La sua fama si è oggi diffusa spontaneamente ed appare unita ad una certa fama di segni. Più che con la parola, Ricci diffuse la fede con la santità della vita, con la carità verso tutti. Papa Francesco più volte ha ricordato la figura di padre Ricci che – ha detto - “è stato grande non solo per le cose che ha fatto che ha scritto, ma è grande perché è stato un uomo di incontri, un uomo della cultura dell’incontro, un uomo che è andato oltre all’essere straniero; è diventato cittadino del mondo”. Padre Matteo Ricci – ha affermato - è stato “tra i primi a stabilire un ponte di amicizia tra la Cina e l’Occidente, attuando un modello tuttora valido di inculturazione del messaggio cristiano nel mondo cinese”.
Fonte: Vatican News
Consulta il nostro Speciale dedicato a Matteo Ricci, che approfondisce il suo contributo allo sviluppo del dialogo fra scienza e fede in Cina
L'Accademia Nazionale dei Lincei pubblica sul proprio sito bandi, premi e borse di studio. Al seguente link l'elenco aggiornato con tutte le posizioni aperte clicca qui
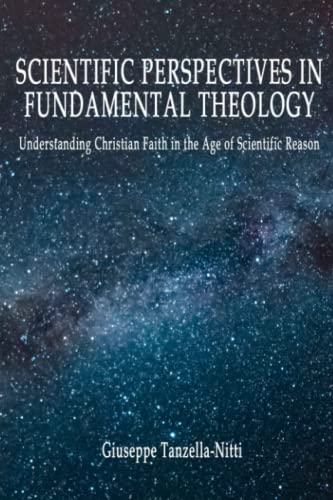 Il libro di Giuseppe Tanzella-Nitti, Scientific Perspectives in Fundamental Theology. Understanding Christian Faith in the Age of Scientific Reason, è stato pubblicato da Claremont Press, California. Il volume contiene una selezione di capitoli originariamente apparsi in ligua italiana nell'opera in 4 volumi Teologia Fondamentale in Contesto Scientifico (Città Nuova, Roma 2015-2022), adattati per un pubblico di lingua inglese.
Il libro di Giuseppe Tanzella-Nitti, Scientific Perspectives in Fundamental Theology. Understanding Christian Faith in the Age of Scientific Reason, è stato pubblicato da Claremont Press, California. Il volume contiene una selezione di capitoli originariamente apparsi in ligua italiana nell'opera in 4 volumi Teologia Fondamentale in Contesto Scientifico (Città Nuova, Roma 2015-2022), adattati per un pubblico di lingua inglese.
pp. 485, $ 19.99
ISBN 978-1946230-55-3
Il Premio Nobel per la Fisiologia e la Medicina è stato assegnato (per intero) a Svante Pääbo, genetista svedese Direttore del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, a Lipsia, in Germania.
La motivazione del prestigioso riconoscimento recita: “per le sue scoperte a proposito dei genomi di ominidi estinti e dell’evoluzione umana”. Pääbo è noto, non solo nella comunità scientifica di appartenenza, per aver sequenziato il genoma dell’uomo di Neanderthal, per aver scoperto una specie di ominidi, oggi nota come Homo di Denisova, studiando il DNA mitocondriale di un frammento di osso di dito ritrovato presso Monti Altaj in Siberia, e per aver mostrato come nel genoma degli attuali H. sapiens (la nostra specie) euro-asiatici si trovino porzioni di DNA neandertalense e denisoviano.
Di fatto, con questi suoi studi, Svante Pääbo ha fondato una nuova disciplina scientifica, detta “paleogenomica”, in grado di recuperare, sequenziare e studiare il DNA di specie estinte a partire da reperti paleontologici. Come si legge nel comunicato stampa per il conferimento: “Attraverso la sua ricerca pionieristica, Svante Paabo ha realizzato qualcosa di apparentemente impossibile: sequenziare il genoma del Neanderthal, un parente estinto degli esseri umani di oggi”.
Il neolaureato premio Nobel per la Medicina 2022 ha rilasciato un’intervista telefonica dalla quale traspare la dedizione alla ricerca e la sensibilità per le implicazioni ampiamente antropologiche e interdisciplinari dei suoi studi specialistici.

L’ing. Giuseppe Locati ci ha lasciato venerdi scorso, 26 agosto 2022, a Monza, sua città natale, all’età di 83 anni. Imprenditore, artista, pensatore, apprezzava da anni le attività del Centro di ricerca DISF e quelle della SISRI, sostenendole. La sua è stata un’attività per molti versi unica. Non è facile trovare un noto imprenditore che, al tempo stesso, sia forse ancor più noto per le sue opere artistiche e conosciuto anche per i suoi libri di filosofia. Attività apparentemente diverse fra loro, ma legate da una visione e unitaria della realtà e della vita, frutto di un pensiero costruito negli anni, con pazienza e con passione. Per l’ing. Locati la realtà era un’unità a molti livelli: non solo materia da modellare in officina perché venisse trasformata in strumenti utili alla vita, ma anche materia da pensare e da meditare, perché luogo dove abita lo spirito, che sprigionava significati sempre nuovi. Erano quei significati che egli cercava di esprimere attraverso le sue opere, con le quali si sforzava di rappresentare le regole del nostro linguaggio e del nostro pensiero. Un uomo appassionato all’unità del sapere, per il quale cultura umanistica e cultura scientifica non erano parti divise di un sapere frammentato, ma aspetti di un’unica comprensione della realtà. Cercava modi per far dialogare fra loro pensiero scientifico e filosofia, ma si dirigeva volentieri anche alla teologia, perché persuaso che le risposte ultime e più profonde della realtà potevano giungere solo considerandola opera di un Creatore.
Conobbi Giuseppe Locati nel 2008, in occasione di un concorso per giovani laureati da lui promosso in collaborazione con i Lions di Monza, allo scopo di stimolare la riflessione sulle grandi domande filosofiche. Scoprimmo subito un intento comune, una passione che adesso ci legava: fornire gli strumenti perché le nuove generazioni non cadessero negli errori del riduzionismo e nel pragmatismo, ma coltivassero una “ragione aperta”, disposta ad andare in profondità, evitando superficialità e pressapochismo. Il “Premio Locati” ebbe diverse edizioni, tutte di grande livello, a varie delle quali fui invitato a prendere parte come membro della Giuria. Nacque così una collaborazione culturale che vide Locati partecipare a Roma ai workshop della SISRI (Scuola Internazionale Superiore per la Ricerca Interdisciplinare) e a sostenere il lavoro che svolgevamo. I giovani restavano ammirati dagli ampi interessi di questo imprenditore brianzolo che maneggiava gli attrezzi dell’officina meccanica e quelli dell’artista con la medesima delicatezza, perché mosso dalla medesima ispirazione. Commentando una delle sue opere, il “Quasi-cubo” (1992), mi diceva: “Vede, da lontano sembra un cubo, razionale, squadrato; da vicino, invece, lo si scopre smussato, di strati e colori diversi, complesso. Così è la realtà. Non è mai chiusa in una fredda razionalità. È ricchissima e poliedrica, ma occorre imparare ad osservarla”.
Oltre alla squisita ospitalità nella loro casa a Monza, accanto alla moglie Elisabetta Galimberti, di Giuseppe Locati ricordo l’ottimismo e l’amore per la riflessione, per la meditazione silenziosa. Una consuetudine a prima vista distante dalle esigenze della vita contemporanea, scandita dai ritmi della produzione e dell’efficienza. Locati amava meditare, passeggiare in silenzio, pregare. La sua fede in Dio creatore era il filo conduttore che univa ispirazione artistica, passione per il lavoro, vita di studio e ricerca intellettuale. Il lavoro, tecnica e arte, era per lui il modo con cui partecipare all’attività creatrice di Dio.
L’ing. Locati ci lascia un esempio straordinario, che ci proponiamo di tener vivo nel tempo, insieme al suo ricordo. Mi piace pensare che la sua ricerca dell’unità, dell’unificazione del molteplice nel semplice, sia stata adesso finalmente soddisfatta dalla contemplazione “dell’Amor che muove il sole e l’altre stelle”, contemplazione con cui Dante Alighieri conclude il suo pellegrinaggio nellaCommedia, speranza di ogni credente nel Risorto.
Giuseppe Tanzella-Nitti
Dal 30 giugno al 3 luglio 2022 si è svolta la sesta edizione del Festival dello Spazio di Busalla (Genova), nella cui cornice si è svolto il concorso a premi per giovani ricercatori, promosso in collaborazione con la Scuola SISRI. Il tema di questa seconda edizione del premio era Itinerari Spaziali, aspetti scientifici, psicologici e culturali delle missioni umane nello Spazio extraterrestre. La mattina di domenica 3 luglio, alle 11, si è avolta la presentazione dei tre elaborati finalisti e la proclamazione del vincitore.
Per saperne di più visita la pagina della Scuola SISRI
In occasione della sesta edizione del Festival dello Spazio di Busalla si indice un concorso a premi per un elaborato con la finalità di coinvolgere giovani impegnati negli studi universitari e nella ricerca che desiderano contestualizzare i loro studi o la loro attività professionale in un più ampio quadro interdisciplinare, attento ai fondamenti umanistici, economici e sociali delle scienze spaziali.
Il Premio è progettato in collaborazione tra l'Associazione Festival dello Spazio di Busalla e la Scuola Internazionale Superiore per la Ricerca Interdisciplinare (SISRI) di Roma ed è patrocinato dall’Agenzia Spaziale Italiana e dall'Università di Genova.
L’elaborato vincitore sarà presentato dal suo autore al Festival dello Spazio 2022, in programma dal 30 giugno al 4 luglio, e sarà pubblicato nella documentazione elettronica e cartacea del Festival.
Il tema del concorso di quest'anno è "Itinerari Spaziali - Aspetti scientifici, psicologici e culturali delle missioni umane nello Spazio extraterrestre". Il concorso è aperto a giovani di nazionalità Europea (stati membri UE ed ESA), di età non superiore ai 35 anni alla data del presente bando, in possesso di un diploma di livello universitario (almeno laurea triennale). L'elaborato dovrà essere inviato entro e non oltre il 29 maggio alla casella mail concorso@festivaldellospazio.com specificando nell’oggetto dell’eventuale email “Concorso Festival dello Spazio 2022- Nome Cognome.
Il Premio per il vincitore consiste in un assegno di 1000,00 euro. Per gli altri due finalisti il premio consiste in un assegno di 250 euro per ciascuno. La proclamazione del vincitore/vincitrice avverrà in occasione del Festival 2022. A tutti e tre sarà data tempestiva comunicazione dell’esito affinché partecipino al Festival dello Spazio 2022 e presentino in pubblico il loro elaborato. Le spese di viaggio dei tre finalisti e la loro accoglienza a Busalla saranno a carico dell’Associazione Festival dello Spazio, ente organizzatore del Festival.
N.B.: la scadenza del concorso è stata posticipata dal 15 maggio (come indicata nel bando), al 29 maggio
Per leggere e scaricare il bando clicca qui
Per conoscere le linee guida per scrivere l'elaborato clicca qui
Per iscriverti al concorso clicca qui
Per tutte le info sul Festival dello Spazio clicca qui
L’Istituto di Scienze Umane ed Esistenziali (ISUE), con l’Università di Colonia, Facoltà di Matematiche e Scienze Naturali, e con il patrocinio dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, annuncia la seconda edizione del premio in memoria di Federico Tonielli, un eclettico dottorando in fisica teorica, scomparso precocemente; la famiglia Tonielli-Ruberti è promotrice del premio.
I primi in realtà sono due borse di studio di euro 1500,00 ciascuna, la prima messo in palio dall’Università di Colonia e rivolta ai dottorandi tedeschi in fisica teorica; la seconda, assegnata dall’ISUE e dalla famiglia aperta ai dottorandi italiani in Storia della Fisica, Storia della Scienza, Filosofia della Scienza, Filosofia della Fisica.
I due premi saranno consegnati in una cerimonia on-line tra i due paesi che quest’anno si svolgerà sabato 4 giugno, probabilmente dalle sedi dell’Università di Colonia e della Scuola Normale di Pisa.
La cerimonia di premiazione sarà preceduta da un workshop aperto alle relazioni di giovani dottorati nelle discipline premiate.
Il Centro Universitario Cattolico (CUC) mira ad aiutare giovani laici aspiranti alla carriera universitaria nel conseguimento della necessaria preparazione scientifica, onde assicurare presso le Università italiane la presenza di docenti che testimonino i valori evangelici nella vita e nell’insegnamento. A tale scopo mette a disposizione per l’anno 2022-2023 n. 16 borse di studio. L’importo di ciascuna borsa è di € 6.000 annui, al lordo delle imposizioni fiscali previste dalla legge.
Clicca qui per leggere e scaricare il bando
Clicca qui per scaricare e compilare la domanda
Il premio Templeton 2022 è stato assegnato oggi a Frank Wilczek, già vincitore del premio Nobel nel 2004, il cui lavoro ha ampliato i confini della nostra conoscenza delle leggi fondamentali dell'Universo. Wilczek, di padre polacco e madre italiana, è nato a New York nel 1951.
Tra i risultati più importanti del suo lavoro vi sono l'aver elaborato una descrizione teorica di una delle quattro forze fondamentali della natura e aver proposto una spiegazione della materia oscura. Si tratta inoltre di un intellettuale pubblico, e in quanto tale ha tenuto spesso conferenze e pubblicato numerosi scritti, in cui ha messo in luce le implicazioni filosofiche delle sue idee. La sua visione dell'Universo è quella di un cosmo che incarna la bellezza matematica sia nel magnificamente grande che nell'inimmaginabilmente piccolo.
Per leggere il regolamento completo clicca qui
L'obiettivo è comunicare e capire il web, l’intelligenza artificiale, il mondo e le sue trasformazioni”. Per questo nasce a Udine una nuova laurea triennale in “Filosofia e trasformazione digitale”. Il digitale sta trasformando tutto. Abbiamo scoperto lo smartworking. Organizziamo le vacanze con le app. Leggiamo le notizie su Internet. Vediamo film in streaming. Acquistiamo online. Facciamo jogging con lo smartphone al braccio. Sosteniamo referendum con la firma digitale. In tanti si chiedono che ne sarà di vecchie professioni, di giornali, sportelli bancari, negozi, cinema, uffici, agenzie di viaggio, partiti.
Di certo, per un mondo che tramonta, ce n'è uno che sta emergendo con forza. Ma per capirne le complessità, per coglierne sia i rischi sia le opportunità è strategico superare un'ottica meramente tecnica, che si focalizza su problemi contingenti e specifici, adottando una prospettiva filosofica: critica, globale, autenticamente innovativa. Approfondendo, attraverso la lente della filosofia, le implicazioni etiche, comunicative, giuridiche, ambientali, economiche, politiche e scientifiche di questo cambiamento epocale, il Corso di Laurea in “Filosofia e Trasformazione Digitale” intende fornire gli strumenti necessari per affrontare le sfide più impegnative del mondo contemporaneo.
L’incontro di presentazione del nuovo corso di laurea, in programma per il 30 aprile, si terrà in aula M3, Strassoldo, Via Tomadini, 30/A. Interverranno Silvia Capodivacca, Roberto Siagri, Alberto F. De Toni e Silvano Tagliagambe. Modera Luca Taddio. L’incontro è dedicato alle scuole del Friuli Venezia Giulia in particolare alle classi V ma è aperto a tutti gli interessati. Il numero massimo dei posti è 350. Per prenotare inviare una mail a silvia.capodivacca@uniud.it
La Scuola Internazionale Superiore per la Ricerca Interdisciplinare, promossa dal Centro di ricerca DISF, “Documentazione Interdisciplinare di Scienza e Fede”, eretto presso la Pontificia Università della Santa Croce di Roma, bandisce in favore dei suoi iscritti un concorso per l’assegnazione di un premio speciale di € 1.000 (mille Euro) al miglior elaborato interdisciplinare pervenuto, presentato sotto forma di un articolo scritto, in lingua italiana o inglese. L’elaborato presentato dovrà vertere su un contenuto collegato con il tema dell’XIII Workshop “Antropocene: l’era dell’umano. L’attività umana nella storia naturale”, che si terrà a Roma nei giorni 21-22 maggio 2022.
L’elaborato dovrà avere un contenuto originale, non pubblicato, ed essere redatto in sintonia con lo stile e la profondità richiesti ad articoli di ricerca (anche se presentato nella forma di un lavoro compilativo) e pertanto corredato dal consueto apparato critico e documentale. Gli elaborati dovranno essere sottoposti entro e non oltre il giorno lunedì 11 aprile 2022 alla Commissione esaminatrice.
Clicca qui per leggere e scaricare il regolamento completo del bando
Papa Francesco ha nominato Cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Peter Kodwo Appiah Turkson. Lo si apprende dal bollettino quotidiano della Sala Stampa della Santa Sede.
Una risorsa per docenti e studenti, completamente gratuita, a servizio delle scuole italiane: è la nuova piattaforma DISF Educational, ideata del Centro di Documentazione Interdisciplinare di Scienza e Fede e sostenuto dalla Conferenza Episcopale Italiana.
Presentato nell'Aula Magna della Pontificia Università della Santa Croce, a Roma, il sito https://disf.org/educational è frutto della collaborazione di oltre 30 professori di tutta Italia. All'evento, che ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di persone tra professori ed esperti del settore, sono intervenuti la senatrice Barbara Floridia, Sottosegretaria al Ministero dell'Istruzione, e mons. Stefano Russo, Segretario Generale Conferenza Episcopale Italiana.
"Sono onorata di essere qui perché qualunque strumento tecnologico, come la piattaforma DISF Educational, messo a disposizione delle nostre scuole, è fondamentale per arricchire il dibattito culturale che nelle scuole deve essere sempre nutrito", le parole della Senatrice Floridia. "Quando il Ministro mi ha dato la delega alla transizione ecologica ho chiesto anche quella culturale perché 'transizione' significa andare verso qualcosa. E oggi questo qualcosa è un nuovo modello abitativo. Un modello - prosegue la Sottosegretaria al Ministero dell'Istruzione - che non può esistere se non modifichiamo quello culturale. Da due anni oramai l'educazione civica è materia disciplinare in tutte le scuole e implica al proprio interno due pilastri del nuovo cittadino: l'educazione digitale e ambientale. E DISF Educational rientra nel primo di questi pilastri. Dobbiamo educare i ragazzi ad abitare la rete, a formare i giovani per i mestieri del futuro. E questa nuova piattaforma è un valido aiuto".
"Fin dalla sua nascita, il centro DISF si è posto in stretto collegamento con il progetto culturale promosso dalla CEI, arricchendolo e mettendo in profondo rapporto il cristianesimo con il progresso tecnologico", afferma mons. Stefano Russo, Segretario Generale della CEI, sottolineando come "DISF Educational, rivolto al mondo della scuola, non è solo uno strumento di istruzione ma è anche un'efficace risposta ai diversi interrogativi che ci sono stati rivolti in questi ultimi tempi. Domande che rientrano non solo nel rapporto tra scuola e tecnologia ma anche nella conoscenza scientifica, ancora troppo poco diffusa. DISF Educational è, altresì, una valida risposta alla domanda di senso che vediamo emergere in tutte le generazioni". "La piattaforma costituisce una risorsa anche per la catechesi e la pastorale giovanile. La facilità della navigazione e l'ampiezza dei temi lo rendono uno spazio davvero adatto a tutti aggiunge mons. Russo -. Nella vastità della rete i percorsi offerti dai siti DISF e DISF Educational contribuiscono a rendere attraente e stimolante l'umanesimo cristiano".
Presenti al tavolo dei relatori anche il professor Luigino Bruni, economista e storico del pensiero economico dell’Università LUMSA di Roma, e il professor Andrea Monda, direttore de L'Osservatore Romano, già docente nelle scuole superiori, e Stefano Oliva, coordinatore del progetto DISF Educational. "Non dobbiamo avere paura di questi strumenti. Il nostro obiettivo è fare cultura in maniera documentata ma sulla rete, mettendo a disposizione di tutti, gratuitamente, quanto appreso durante l'esperienza ventennale del centro DISF", afferma Oliva illustrando, sito alla mano, la piattaforma Educational.
“È bello che ci sia una piattaforma gratuita in un mondo dove il mercato sta occupando tutti gli spazi. Avere dei luoghi di gratuità oggi è come una piazza con una fontana da cui attingere gratuitamente. Perché oggi la conoscenza sta diventando una merce, ma c'è una conoscenza che non si può pagare. E il fatto che anche la CEI abbia creduto in questa operazione è molto apprezzabile", il commento del professor Bruni, che ammonisce: "La grande sfida di oggi è raccontare la società occidentale, all'interno della quale c'è anche l'umanesimo ebraico-cristiano, con nuovi linguaggi. Se falliremo in questo, in vent'anni bruceremo tremila anni di storia. In questa prospettiva, il lavoro di DISF Educational è importantissimo perché dentro c'è tutto. La dimensione narrativa oggi è decisiva e questa piattaforma, che si rivolge nelle scuole, sta facendo proprio questo: crea nuove narrative. E non si limita solo a questo perché pone 'grandi domande' ai giovani, li invita ad alzare lo sguardo verso l'infinito. Questa è la chiave: il dialogo tra scienza e fede porta un ragazzo a guardare verso il cielo e a fargli capire che non esiste solo lo smartphone".
"Dov'eravate quando avevo bisogno di voi", le parole con cui apre il suo intervento il professor Andrea Monda, direttore de L'Osservatore Romano. "Quando ero insegnante di religione uno studente (era il primo giorno di scuola, entrando in classe e presentandomi) mi domanda: 'Ancora religione? La scienza ha spiegato tutto'. All'inizio rispondevo agli alunni ma poi ho capito che ai ragazzi non bisogna rispondere ma porre domande. E questa piattaforma fa proprio questo: mette insieme tecnologia e domande, fornendo un aiuto valido alla crescita personale dei ragazzi".
La piattaforma DISF Educational
L’obiettivo della piattaforma, completamente gratuita ed esente da pubblicità, è dotare le scuole superiori del Paese di un nuovo strumento, finora assente, che aiuti ad affrontare i dibattiti sui principali temi di attualità che richiedono il convergere di diverse materie e prospettive per essere trattati, in modo convincente, anche sui banchi di scuola. Completamente esente da pubblicità, DISF Educational contiene oltre mille pagine web originali e si compone di quattro grandi rubriche: “Percorsi tematici”, “Grandi domande”, “Cercatori di senso”, “Video interdisciplinari”.
Percorsi tematici
Definiti con l’aiuto di un panel di esperti e tenendo presenti le Indicazioni nazionali del Ministero dell’Istruzione, DISF Educational offre ai docenti 30 “Percorsi Tematici” tra i principali snodi storici e concettuali associati ad uno specifico tema che lega trasversalmente più materie di insegnamento, soffermandosi, in modo particolare, sulle questioni scientifiche che sollecitano la filosofia e la religione cattolica. Fra i titoli compaiono: “La rivoluzione scientifica e la nostra immagine del mondo”; “Il secolo dei Lumi: aspetti del rapporto fra fede e ragione in età moderna”; “Le dinamiche dell’ecosfera, la responsabilità e la cura del pianeta”; “La biologia e gli interrogativi sulla natura, l’origine e l’evoluzione dei viventi”. Non solo: ad ogni percorso tematico sono associate delle “Tracce di lavoro” da poter svolgere in classe o da affidare al lavoro personale degli studenti.
Grandi domande
La rubrica “Grandi Domande” raccoglie anch’essa 30 interrogativi che coinvolgono una prospettiva che è sia scientifica che umanistica, fornendo risposte fruibili nel contesto della didattica delle scuole superiori, ma utili anche agli insegnanti delle scuole medie. A ogni domanda principale il modulo didattico associa varie domande secondarie, più specifiche, e diversi box di approfondimento con links che rimandano ad altri documenti. Ogni “Grande domanda” è poi accompagnata da un glossario.
Cercatori di senso
Cuore del sito DISF Educational è la rubrica “Cercatori di senso” nella quale si accede attraverso alcune “porte” alle principali domande ed esperienze che caratterizzano la nostra società. Una sorta di parola-chiave che ogni ragazzo può ritrovare nella letteratura, nella filosofia come nelle scienze, ma anche nel cinema e nell’arte. Conoscere, destino, stupore, coscienza, fragilità, amore sono solo alcune di queste “porte” presenti su DISF Educational che si aprono su riflessioni in rapporto con le risposte consegnate, nel corso dei secoli, dal cristianesimo alla storia. Il tutto esaminato nella più ampia cornice di un dialogo tra fede e cultura.
Video interdisciplinari
Integra la piattaforma una rubrica di brevi video finalizzata a fornire le risposte essenziali ad alcuni specifici problemi di attualità, dalle neuroscienze alla dimensione etica delle nuove tecnologie, dalle dimensioni filosofiche della ricerca scientifica all’inverno demografico, dalla specificità dell’essere umano nel panorama dei viventi alla vicenda storica di Galileo Galilei. Realizzati con la consulenza di esperti del mondo della scuola e della comunicazione, 28 video comprendono brevi interviste, testi e commenti in relazione con gli argomenti presenti sulla piattaforma. Fra questi, la traduzione sottotitolata in lingua italiana di alcuni video prodotti dall'American Association for the Advancement of Science (AAAS) all'interno del Programma Dialogue on Science, Ethics and Religion (DoSER), partner di DISF Educational.
Sarà presentata nel pomeriggio di mercoledì 16 febbraio 2022, a partire dalle ore 17.30, nell’Aula Magna della Pontificia Università della Santa Croce di Roma, la nuova piattaforma DISF Educational: un progetto innovativo dedicato a docenti e studenti delle scuole superiori di tutta Italia.
All’evento, che si svolgerà in presenza (sarà garantita anche una diretta streaming) parteciperanno la prof.ssa Cristina Reyes, Vice Rettore Pontificia Università della Santa Croce, la Sen. Barbara Floridia, Sottosegretaria di Stato, Ministero dell'Istruzione, Mons. Stefano Russo, Segretario Generale Conferenza Episcopale Italiana, il Prof. Mario Rusconi, Associazione Nazionale Presidi – Roma.
Alla tavola rotonda, dal titolo “Scuola, società e nuove generazioni”, interverranno come relatori il prof. Luigino Bruni, economista e storico del pensiero economico dell’Università LUMSA di Roma e il prof. Andrea Monda, direttore di Osservatore Romano, già docente nelle scuole superiori. A moderare l’incontro sarà Letizia Davoli, giornalista scientifica di TV2000.
Promosso dal Centro di Documentazione Interdisciplinare di Scienza e Fede e sostenuto dalla Conferenza Episcopale Italiana, DISF Educational è frutto della collaborazione di oltre 30 professori di tutta Italia. L’obiettivo della piattaforma, completamente gratuita, è dotare le scuole superiori del Paese di un nuovo strumento, finora assente, che aiuti ad affrontare i dibattiti sui principali temi di attualità che richiedono il convergere di diverse materie e prospettive per essere trattati, in modo convincente, anche sui banchi di scuola.
Completamente esente da pubblicità, DISF Educational contiene oltre mille pagine web originali e si compone di quattro grandi rubriche: “Percorsi tematici”, “Grandi domande”, “Cercatori di senso”, “Video interdisciplinari”.
Percorsi tematici
Definiti con l’aiuto di un panel di esperti e tenendo presenti le Indicazioni nazionali del Ministero dell’Istruzione, DISF Educational offre ai docenti 30 “Percorsi Tematici” tra i principali snodi storici e concettuali associati ad uno specifico tema che lega trasversalmente più materie di insegnamento, soffermandosi, in modo particolare, sulle questioni scientifiche che sollecitano la filosofia e la religione cattolica. Fra i titoli compaiono: “La rivoluzione scientifica e la nostra immagine del mondo”; “Il secolo dei Lumi: aspetti del rapporto fra fede e ragione in età moderna”; “Le dinamiche dell’ecosfera, la responsabilità e la cura del pianeta”; “La biologia e gli interrogativi sulla natura, l’origine e l’evoluzione dei viventi”. Non solo: ad ogni percorso tematico sono associate delle “Tracce di lavoro” da poter svolgere in classe o da affidare al lavoro personale degli studenti.
Grandi domande
La rubrica “Grandi Domande” raccoglie anch’essa 30 interrogativi che coinvolgono una prospettiva che è sia scientifica che umanistica, fornendo risposte fruibili nel contesto della didattica delle scuole superiori, ma utili anche agli insegnanti delle scuole medie. A ogni domanda principale il modulo didattico associa varie domande secondarie, più specifiche, e diversi box di approfondimento con links che rimandano ad altri documenti. Ogni “Grande domanda” e poi accompagnata da un glossario.
Cercatori di senso
Cuore del sito DISF Educational è la rubrica “Cercatori di senso” nella quale si accede attraverso alcune “porte” alle principali domande ed esperienze che caratterizzano la nostra società. Una sorta di parola-chiave che ogni ragazzo può ritrovare nella letteratura, nella filosofia come nelle scienze, ma anche nel cinema e nell’arte. Conoscere, destino, stupore, coscienza, fragilità, amore sono solo alcune di queste “porte” presenti su DISF Educational che si aprono su riflessioni in rapporto con le risposte consegnate, nel corso dei secoli, dal cristianesimo alla storia. Il tutto esaminato nella più ampia cornice di un dialogo tra fede e cultura.
Video interdisciplinari
Integra la piattaforma una rubrica di brevi video finalizzata a fornire le risposte essenziali ad alcuni specifici problemi di attualità, dalle neuroscienze alla dimensione etica delle nuove tecnologie, dalle dimensioni filosofiche della ricerca scientifica all’inverno demografico, dalla specificità dell’essere umano nel panorama dei viventi alla vicenda storica di Galileo Galilei. Realizzati con la consulenza di esperti del mondo della scuola e della comunicazione, 28 video comprendono brevi interviste, testi e commenti in relazione con gli argomenti presenti sulla piattaforma. Fra questi, la traduzione sottotitolata in lingua italiana di alcuni video prodotti dall'American Association for the Advancement of Science (AAAS) all'interno del Programma Dialogue on Science, Ethics and Religion (DoSER), partner di DISF Educational.
Clicca qui per scaricare la locandina dell'evento
Clicca qui per leggere il programma completo dell'evento
Il dottor Robert Russel ha annunciato il suo pensionamento, dal prossimo giugno, sia come Presidente del CTNS (Center for Theology and the Natural Sciences) che come Professore della cattedra di Theology and Science intitolata a Ian G. Barbour. Il Centro celebra i suoi 40 anni di presidenza, ricordando come abbia aperto la strada agli studiosi di tutto il mondo che si occupano di scienza e teologia fondando il CTNS e facendolo crescere fino a diventare quello che è oggi. Durante il suo mandato come presidente del CTNS, il dottor Russell ha insegnato e supervisionato il lavoro di 35 dottorandi e centinaia di studenti, ha istituito la cattedra "Ian G. Barbour" in Teologia e Scienza, ha creato due programmi di borse di studio e ha co-fondato la rivista Theology and Science.
Dal 1 luglio 2022 verrà dunque sostituito dal dottor Braden Molhoek, che ha lavorato a lungo nel campo della filosofia morale e della bioetica, ed ha approfondito in particolare il tema del rapporto fra etica e tecnologia.
Per rafforzare la presenza femminile nel mondo della Fisica e della Scienza, e al fine di valorizzare le ricercatrici di talento, la Società Italiana di Fisica bandisce su proposta del Comitato Pari Opportunità, un Concorso per assegnare due premi di Euro 2.000,00 (duemila) e diploma, da assegnare a due laureate in fisica che si siano particolarmente distinte negli ultimi 5 anni con le loro ricerche ed appartenenti a due diverse fasce di esperienza (early career & mid to full career), ovvero con anzianità di laurea magistrale minore o maggiore di 10 anni.
Le norme di partecipazione al Concorso sono le seguenti:
- 1) Al concorso sono ammesse le Socie della Società Italiana di Fisica che abbiano fatto pervenire la quota sociale per l’anno 2024 entro l'8 maggio 2024 (*).
- 2) La domanda di ammissione al Concorso, recante le generalità e il recapito della concorrente, deve essere effettuata per le vie telematiche utilizzando l’apposito modulo scaricabile
qui. Ogni domanda completa della relativa documentazione dovrà pervenire per posta elettronica all’indirizzo premio.laurabassi@sif.it entro l'8 maggio 2024.
- 3) Alla domanda la concorrente dovrà unire, sempre per le vie telematiche, i seguenti documenti:
- a. il curriculum vitae et studiorum;
- b. una relazione scientifica illustrante l’attività di ricerca svolta;
- c. l’elenco delle pubblicazioni;
- d. ogni altro documento che ritenga utile ai fini del Concorso.
- 4) La candidata dovrà procurare a corredo della domanda almeno una lettera di presentazione (non più di 300 parole) redatta da una persona referee, secondo le seguenti modalità: il o la referee, preferibilmente di Istituzione diversa da quella di appartenenza della candidata, invierà la lettera in formato .pdf per posta elettronica all’indirizzo premio.laurabassi@sif.it entro l'8 maggio 2024 indicando nell’oggetto “Premio Laura Bassi - nome e cognome della candidata”.
- 5) Il ritardo nella presentazione o nell’arrivo della domanda con la relativa documentazione, qualunque ne sia la causa, anche non imputabile alla candidata, comporterà l’inammissibilità dell’aspirante al Concorso.
- 6) Una Commissione Scientifica nominata dal Consiglio di Presidenza della SIF esaminerà le domande pervenute e proporrà il vincitore. Il Consiglio di Presidenza della SIF attribuirà il relativo premio.
- 7) Il premio verrà conferito in occasione del prossimo 110° Congresso Nazionale della Società Italiana di Fisica che si terrà a Bologna, 9-13 settembre 2024.
(*)Eccetto per i Soci Invitati.